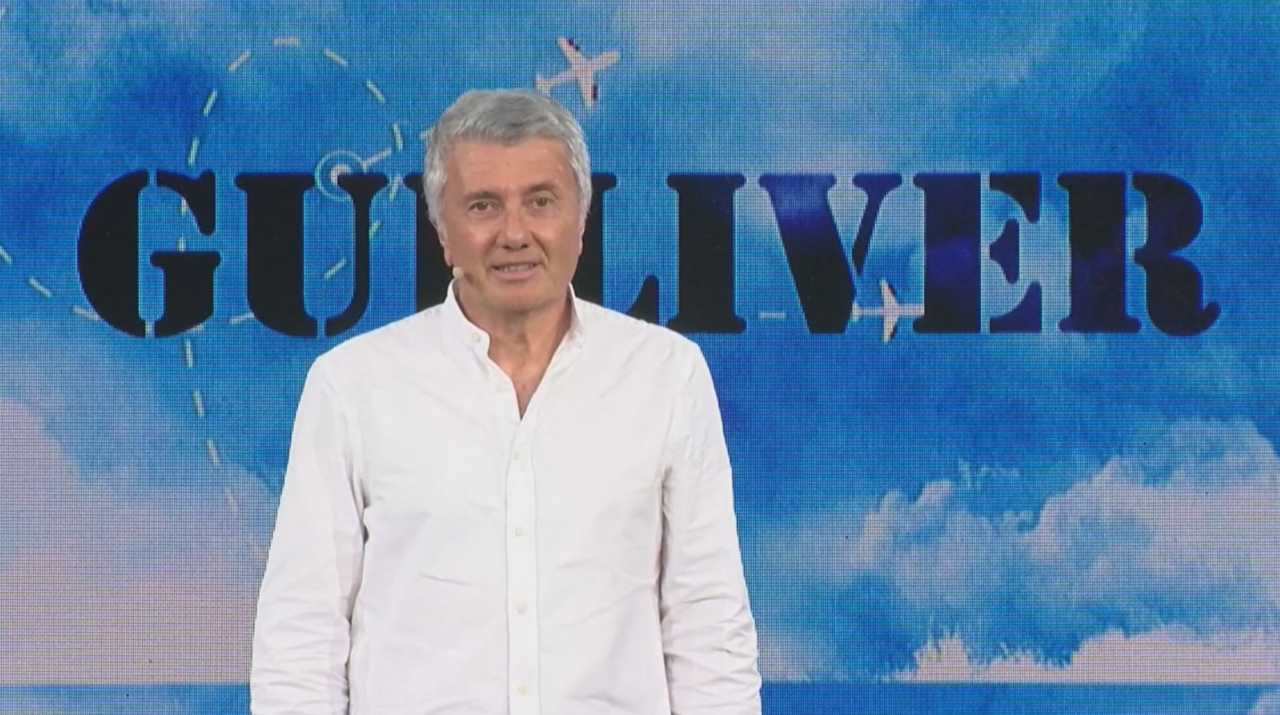di Stefano Ribaldi*
«Nel deserto avevo trovato una libertà irraggiungibile nella civiltà; una vita non appesantita dai possedimenti, perché tutto ciò che non era necessario diventava un ingombro… Nessun uomo può vivere questa vita e uscirne immutato. Porterà con sé, anche se in modo impercettibile, l’impronta del deserto»: così lo scrittore Wilfred Thesiger racconta il suo incontro con l’immensa distesa di sabbia sahariana. L’ingombro da lui ricordato è al tempo stesso fisico e interiore e si materializza man mano che ci avviciniamo all’oasi di Merzouga, un tempo punto di sosta lungo le piste che attraversavano il Sahara, ai bordi dell’Algeria, ora luogo di partenza e di arrivo dei turisti che lo visitano. A breve distanza si trovano le dune dell’Erg Chebbi, uno dei grandi gruppi di dune che si trovano nella parte meridionale del Marocco. Pian piano il paesaggio muta e dalla pianura verdeggiante si trasforma in distesa di pietre arse al sole contornate da piante grasse fino a diventare un ecosistema estremo dove sabbia, vento e luce modellano lo spazio, che non concede riparo. Ovviamente le nostre guide ne sono gli interpreti e ci conducono a dorso di cammello in fila indiana come scolaretti impacciati dal nostro rigido peso. Una giornata passata a girovagare senza meta, ma esiste una meta nel deserto? Con le scarpe piene di sabbia, arranchiamo per salite e discese, ondeggiando goffamente sui simpatici cammelli che si strusciano per gioco, per pigrizia o per sollievo da pulci e mosche sulle nostre gambe con i loro lunghi colli. Dopo aver contemplato il sole che si inabissa sulla sabbia accendendo di color rosso pastello il nulla che ci circonda, ci ritroviamo in un lussuoso accampamento al margine fra deserto e strada statale. Giusto il tempo di dormire perché la mattina presto ci aspetta un lungo viaggio fra le montagne dell’Atlante lungo la valle del Ziz per arrivare al palmeto di Tinghir, fra scenari aridi con aspre catene montuose, intervallate da distese di oasi rigogliose che sembrano ribadire la ferma volontà di resilienza della natura. Arriviamo quindi alla kasbah di Tinghir, sorta tra il XVII e il XVIII secolo, in un periodo di equilibri politici fragili, rivalità tribali e controllo strategico delle risorse. Residenza del Caid locale, la fortificazione difendeva l’elemento più prezioso: l’acqua con le terre coltivate. Dalla collina controllava il territorio e le vie carovaniere di merci di valore come sale, datteri, spezie e tessuti, in collegamento fra il Sahara e le città imperiali. Costruita in terra cruda e paglia, la kasbah si presenta come una massa compatta color ocra, quasi una naturale estensione della roccia e della sabbia circostanti, creando un effetto di forte suggestione. Le mura spesse, interrotte da torri angolari merlate, servivano a proteggere famiglie e raccolti. Oggi raccontano una storia di potere locale, di vita comunitaria e di adattamento all’ambiente estremo. All’interno, gli spazi sono organizzati attorno a cortili ombreggiati, con scale ripide, passaggi stretti e stanze sovrapposte. La luce entra filtrata, creando contrasti netti tra ombra e sole; in un angolo un incantatore di serpenti rapisce la nostra attenzione con la sua ritmata nenia con cui blandisce il rettile e il nostro sguardo. Andare a Oriente significa cercare inconsapevolmente le nostre origini. Il Marocco non lo si attraversa soltanto, lo si ascolta, lo si osserva, lo si ricorda. Perché questo Paese è un luogo dove il tempo non scorre in linea retta, ma si deposita, come sabbia.
*autore e produttore tv